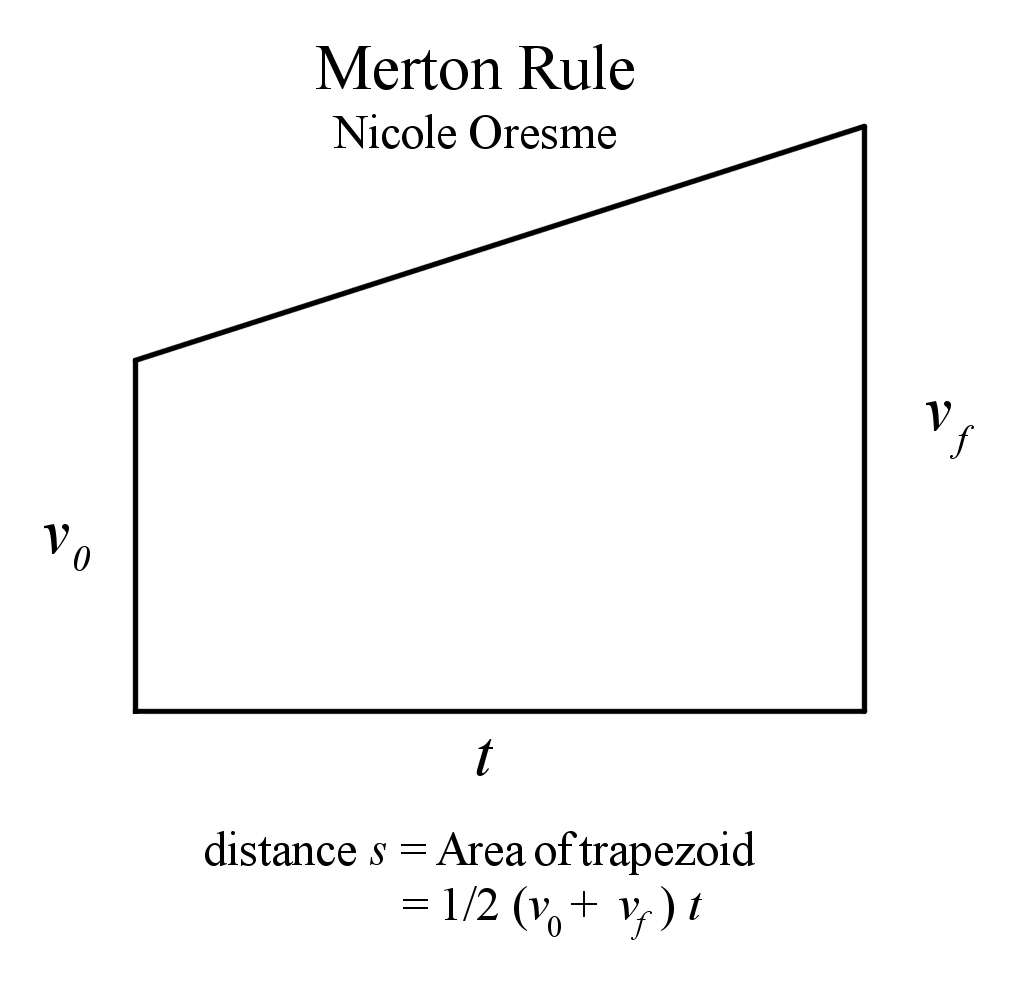L'etica
kantiana e i suoi 4 teoremi
Il
primo teorema:
«Tutti
i principi pratici, che presuppongono un oggetto (materia) della
facoltà di desiderare come motivo determinante della volontà, sono
empirici e non possono fornire leggi pratiche.» (Kant, Immanuel,
Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1909, p.39-41)
Dimostrazione:
Kant
intende per oggetto della facoltà di desiderare la rappresentazione
dell'oggetto desiderato. Un principio che ha come fine la
realizzazione di tale oggetto è un principio pratico empirico.
Infatti Kant afferma che un principio di tal fatta avrebbe come scopo
il piacere, in quanto piacevole è la soddisfazione del desiderio.
Dal momento che non si può determinare a priori se con la
realizzazione del desiderio corrisponderà un piacere, questo può
avvenire solo per via empirica, quindi a posteriori. Potrà dunque
esserci una massima come principio pratico empirico, ma non sarà una
legge, proprio perché le leggi sono a priori.
Il
secondo teorema:
«Tutti
i principi pratici materiali, come tali, sono di una sola e medesima
specie, e appartengono al principio universale dell'amor proprio,
ossia della propria felicità.» (Kant, Immanuel, Critica della
ragion pratica, Laterza, Bari, 1909, p.41)
Dimostrazione:
Qui
per principio pratico materiale Kant intende sempre i principi
pratici empirici, quindi quei principi pratici che mirano al
soddisfacimento del desiderio, ossia al piacere. Cercare in ogni modo
di conseguire il piacere consiste nell'essere umano nella ricerca
della felicità. Fare della felicità il motivo determinante delle
proprie azioni, afferma Kant, costituisce il principio dell'amor
proprio. Siccome tutti i principi pratici materiali hanno la stessa
caratteristica (perseguono tutti il piacere), allora sono tutti della
medesima specie.
Il
terzo teorema:
«Se
un essere razionale deve concepire le sue massime come leggi pratiche
universali, esso può concepire queste massime soltanto come principi
tali che contengano il motivo determinante della volontà, non
secondo la materia, ma semplicemente secondo la forma.» (Kant,
Immanuel, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1909, p.55)
Dimostrazione:
Con
materia di un principio pratico Kant intende l'oggetto a cui la
volontà mira, quindi l'oggetto desiderato. Se il motivo determinante
della volontà è un oggetto, perciò l'azione è condizionata
patologicamente, allora il principio che la guida non è una legge.
Se si astrae dalla materia della legge, ne rimane la pura forma. È
la forma della massima che deve guidare l'uomo morale.
Il
quarto teorema:
«L'autonomia
della volontà è l'unico principio di tutte le leggi morali e dei
doveri che loro corrispondono: invece ogni eteronomia del libero
arbitrio, non solo non è la base di alcun obbligo, ma piuttosto è
contraria al principio di questo e alla moralità della volontà.»
(Kant, Immanuel, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1909,
p.71)
Dimostrazione:
Kant
definisce come unico principio di moralità la determinazione
dell'agire dell'uomo mediante la sola forma della legge e non
mediante la materia. L'indipendenza dell'uomo dall'oggetto o della
materia è una libertà negativa, afferma Kant, ma la capacità
dell'uomo di determinarsi tramite legge è una forma di libertà
positiva. L'uomo è autonomo in quanto è capace di autodeterminarsi,
ossia agire a partire dalla legge che è prescritta dalla sua stessa
ragione.
Articolo:
http://filosofia-orconerocapoguerra.blogspot.com/2017/12/letica-kantiana-e-i-suoi-quattro.html